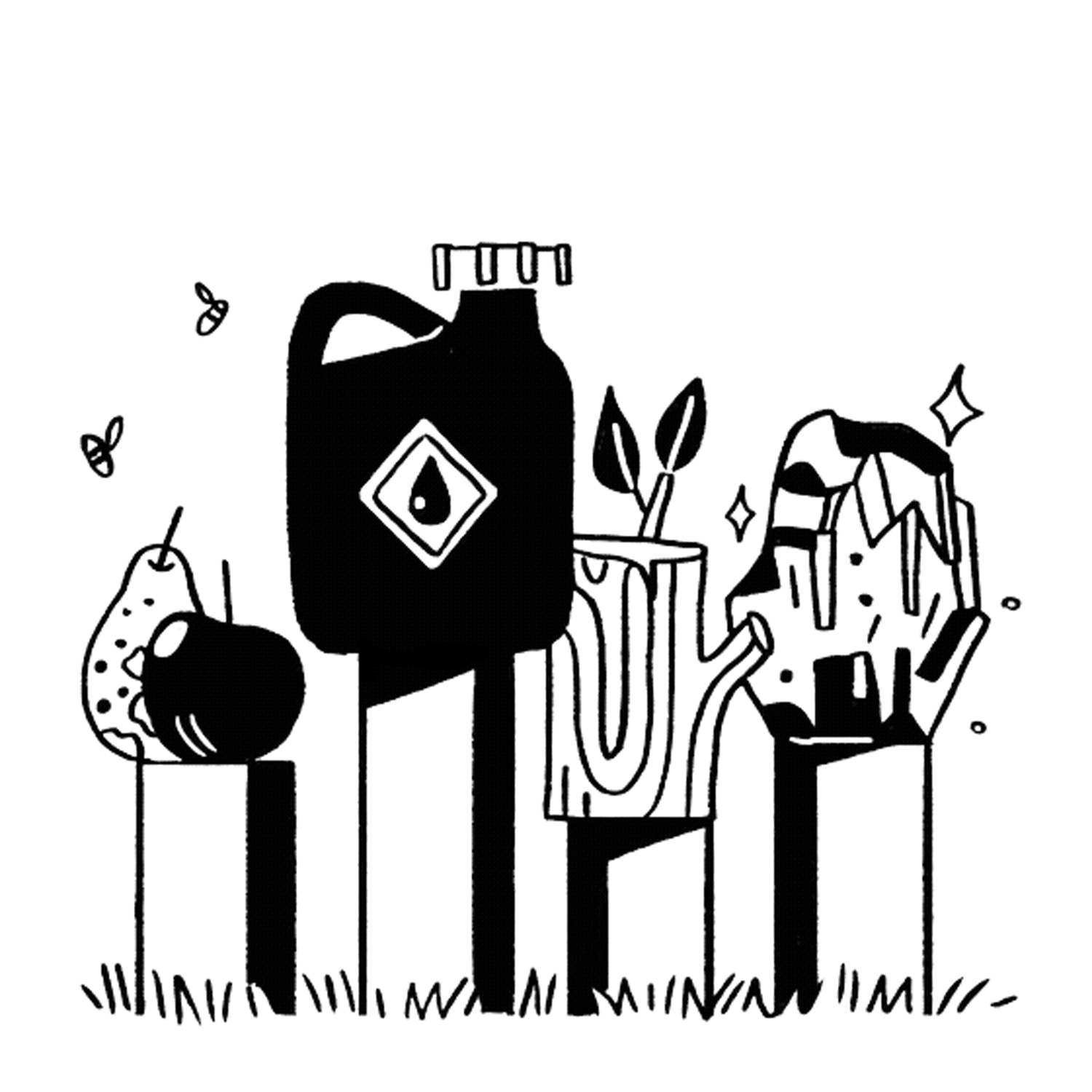Nelle Borse il 2026 non è cominciato in anticipo: è cominciato senza chiedere permesso. Non da Wall Street, ma da Washington. L’azione americana in Venezuela non è stata solo una violazione della grammatica diplomatica. È stata una dichiarazione implicita: quando serve, le regole diventano opzionali. E i mercati, che capiscono i segnali meglio delle cancellerie, lo hanno registrato subito. Senza panico. Peggio: quasi con indifferenza.
È sempre così all’inizio dei cambi di fase. Volatilità bassa, indici alti, commentatori rassicuranti. L’aria cambia, ma nessuno apre la finestra. Si continua a parlare di rally, di soft landing, di intelligenza artificiale come nuova religione secolare, mentre sotto traccia si comincia a riscrivere il manuale del rischio globale. Non più solo scenari da valutare, ma decisioni unilaterali da prezzare. E soprattutto tempi sempre più compressi. La storia accelera, e quanto accaduto a Caracas è un netto cambio di paradigma. Guai a chi non si accorge per tempo.
A dieci giorni dall’inizio dell’anno nuovo il clima è questo: ottimismo ostinato, volatilità anestetizzata, mercati convinti che il futuro sia una semplice estensione del presente. Le domande ufficiali restano quelle comode: bolla dell’IA sì o no? Oro contro dollaro? Deficit americano sostenibile o problema di domani? Quanto inciderà il blitz di Trump sul trend del petrolio? Questioni legittime, ma in un certo senso secondarie. Perché il vero elefante nella stanza è un altro: se una sovranità può essere rimossa per decisione politica, per quanto umanamente giusta, cosa significa davvero la parola “rischio” oggi? I mercati non temono l’evento. Temono il precedente, anche quando non lo ammettono.
E infatti la festa continua. Ma è proprio quando la musica non si ferma che conviene chiedersi chi pagherà il conto. Perché il Cigno Nero, quello vero, non arriva mai da dove lo si aspetta. Potrebbe non avere nulla a che fare con l’IA. Potrebbe sbucare dall’economia reale, che la finanza non ha fatto in tempo a impacchettare in una slide o ha scelto distrattamente di ignorare: una frenata dei consumi, una crisi del credito, una geopolitica che smette di essere rumore di fondo e alza la voce in Venezuela. La storia è nota, ma ogni volta sorprende: i mercati non crollano per ciò che vedono, ma per ciò che sottovalutano. E oggi si sottovaluta soprattutto il rischio, mentre si sopravvaluta la comodità.
Il 2026 si è aperto così, con un ottimismo prudente nei report, spavaldo nei portafogli. Multipli tirati, aspettative elevate e una fiducia quasi religiosa nel fatto che «questa volta è diverso». È qui che entrano in scena i consulenti pigri, quelli che confondono la semplificazione con la competenza. Il loro strumento preferito è sempre lo stesso: il rapporto prezzo/utili per azione (più noto come price/earning o p/e). Un indicatore che per decenni ha funzionato, e proprio per questo oggi viene usato come scorciatoia mentale. Basta un numero, possibilmente basso o confrontabile con una media storica, e il lavoro sembra fatto. Peccato che il mondo sia cambiato.
Aswath Damodaran, professore alla Nyu Stern e autorità mondiale nelle valutazioni aziendali, lo ripete senza giri di parole: l’analisi fondamentale non è sintesi, è cosa complessa. Ridurla a un solo indicatore non è rigore, è pigrizia. Il p/e dice qualcosa, ma spesso dice la cosa sbagliata, soprattutto se applicato in modo indiscriminato a società con crescita, rischi e strutture finanziarie opposte. Edward Yardeni, spesso citato nelle note di investimento delle grandi case, è altrettanto netto: usare il p/e come bussola universale in un mercato dominato da big tech e modelli asset-light equivale a fare consulenza con il pilota automatico inserito.
Persino Warren Buffett, che non ha mai disprezzato i numeri semplici, poco prima di lasciare il suo leggendario Berkshire Hathaway ha avvertito che affidarsi al solo p/e è il modo più rapido per prendere cantonate memorabili. Il problema è che il p/e fa comodo: non considera la crescita futura degli utili, ignora il debito, trascura i flussi di cassa ed è estremamente sensibile a profitti ciclici o manipolabili; ma consente di dare risposte rapide, rassicuranti, vendibili a chi non è del mestiere. In un’industria che spesso premia la tranquillità apparente più della verità scomoda, non è un dettaglio.
A complicare tutto c’è l’eredità delle politiche fiscali e monetarie dell’ultimo decennio. Tassi prima artificialmente compressi, poi improvvisamente restrittivi hanno alterato il costo del capitale e reso le valutazioni poco confrontabili nel tempo. Continuare a usare gli stessi parametri di ieri significa guardare il presente con lenti appannate. E poi ci sono le big tech, che non somigliano più alle aziende per cui il p/e era stato pensato. Investimenti immateriali, potere sistemico, margini elevati e scalabilità globale rendono l’utile contabile una fotografia parziale, quando non fuorviante. Oggi contano la qualità dei flussi di cassa, la durata del vantaggio competitivo, la capacità di difendere i margini quando il ciclo gira.
Detronizzare il p/e non è un atto di ribellione, ma di responsabilità. Significa smettere di vendere certezze facili e tornare a fare analisi vera. Perché in tempi di possibile Cigno Nero il rischio non è sbagliare valutazione, ma non capire cosa si ha in portafoglio. Quando il mercato scende tutto insieme, molti titoli cadono per trascinamento, non per colpa dei fondamentali. Saperlo prima fa la differenza: si vende meno per paura, si ragiona di più e si investe quando vale la pena. Forse è questa la vera lezione con cui il 2026 si apre: meno formule ripetute a memoria, più pensiero critico. Anche se costa fatica. Anche se non sta in una riga di un report. Soprattutto quando il cielo sopra le Borse sembra ancora perfettamente sereno.
Leggi anche:
1. Venezuela, impatto limitato sui mercati”. Le previsioni degli analisti
2. Non solo petrolio: che fine farà l’oro del Venezuela finito in Svizzera?
© Riproduzione riservata