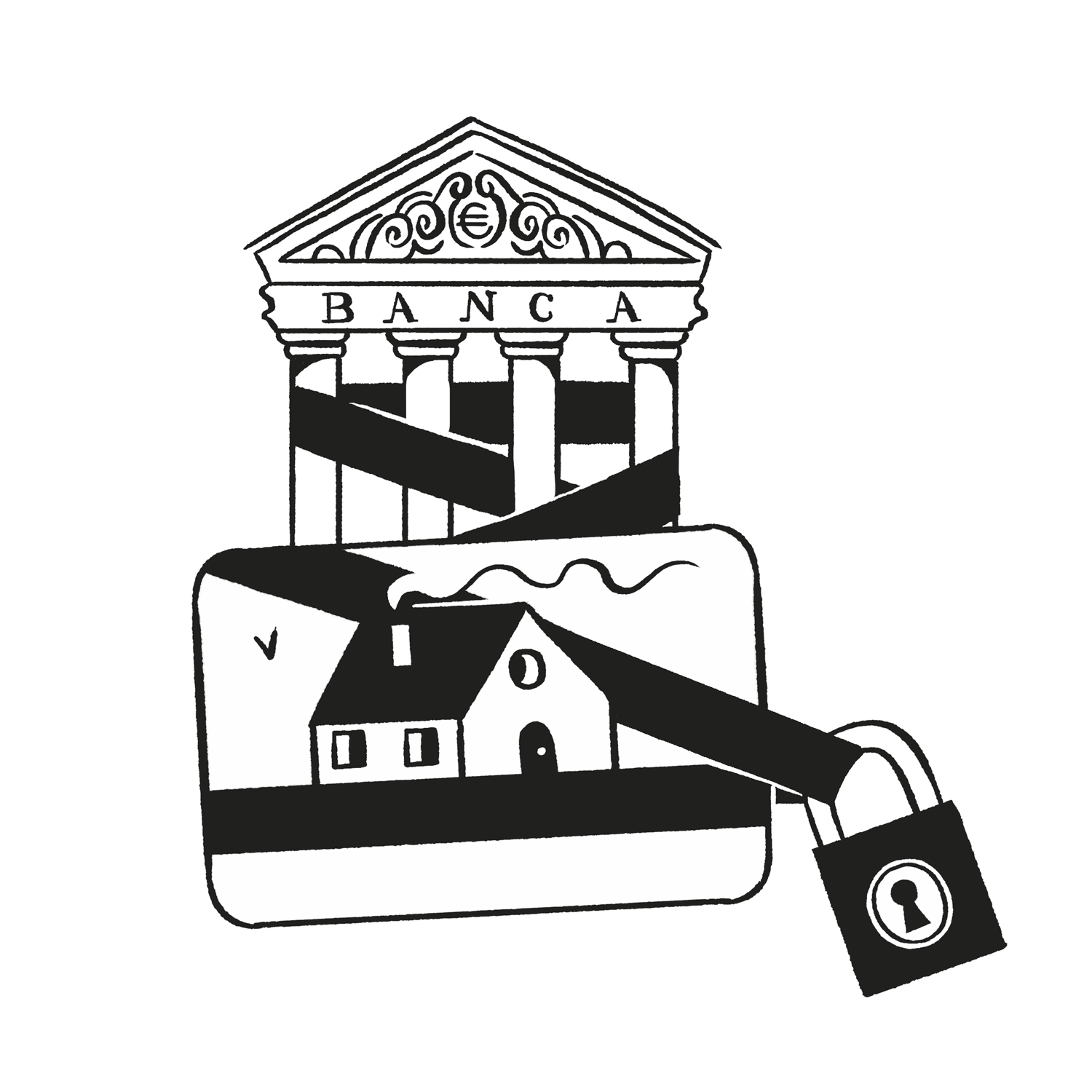Il welfare fa bene ai lavoratori e alle aziende, può aumentare del 20% la produttività (in Italia la più bassa d’Europa), può abbattere del 16% il costo delle risorse umane, può generare un valore aggiunto di 60mila euro per dipendente. Ma parlare di welfare in azienda non basta, bisogna scegliere quale attenzione rivolgere ai propri collaboratori. I risultati indicati sono quelli che derivano da una scelta organizzata di «corporate wellbeing», così come l’ha misurata la terza edizione dell’Osservatorio sul corporate wellbeing promosso da Jointly, provider di welfare aziendale e non solo, in collaborazione con Teha Group, The European House Ambrosetti.
Dal 2016 in poi le esperienze di welfare aziendale – grazie a una normativa sempre più attenta alle opportunità di integrazione di benefici defiscalizzati per aziende e lavoratori – si sono moltiplicate. Tiziano Treu parlò di «welfare aziendale di massa», una sorta di rivoluzione nella gestione delle risorse umane: buoni pasto, benefit di varia natura (dalla palestra all’asilo nido per i figli dei dipendenti), polizze sanitarie integrative sono diventati un’esperienza diffusa, anche grazie all’evoluzione della contrattualizzazione.
Ma si profila una nuova «rivoluzione» che va oltre i benefit e i vantaggi fiscali (che in qualche modo hanno integrato anche la debole crescita dei salari): il «corporate wellbeing». Il benessere dei dipendenti è perseguito in modo trasversale all’interno dell’organizzazione: la sponsorship parte dal ceo e dalla linea manageriale, la funzione Hr diventa strategica e la cultura aziendale si orientata a supportare la competitività dell’azienda in termini di attrattività, retention e produttività.
Il «corporate wellbeing» genera un triplice vantaggio per l’azienda: più produttività (+20% di valore aggiunto per dipendente, secondo l’indagine Jointly-Teha), meno turnover (con un risparmio fino al 16% sul costo del personale) e maggiore efficienza del costo del lavoro (ogni euro investito in «wellbeing» può valere fino a 4,5 volte per i lavoratori, grazie al moltiplicatore economico). Ignorare il benessere organizzativo comporta costi nascosti elevati e perdita di competitività. A oggi, però, più del 61% dei contratti aziendali contiene misure di welfare incentrate per la maggior parte solo su benefici fiscali, che spesso non riescono a rispondere in maniera efficace né alle esigenze organizzative né ai bisogni sociali dei lavoratori.
La ricerca (che nasce dall’intervista di 120 ceo, e altrettanti Hr director) evidenzia che il successo delle iniziative non dipende solo dai benefit offerti, ma da come il benessere viene integrato nella strategia delle risorse umane. Adottare misure di welfare aziendale «tradizionale» – dai buoni pasto ai rimborsi – è utile, ma non è più sufficiente. Diventa invece essenziale che le imprese evolvano da una concezione puramente fiscale del welfare aziendale a una più ampia strategia di benessere organizzativo.
A guidare i modelli più efficaci sono cinque leve fondamentali: governance, ascolto, comunicazione, misurazione dei risultati e offerta di servizi. La presenza o meno di una strategia integrata per il benessere organizzativo varia anche in base alle dimensioni aziendali: se, infatti, solo tre imprese su dieci con meno di 250 dipendenti hanno avviato strumenti o programmi specifici, la quota sale a quasi una su due tra le aziende medio-grandi (250-500 dipendenti) e raggiunge otto su dieci tra quelle con oltre 500 dipendenti.
Un altro dato rilevante è il cosiddetto «wellbeing mismatch»: nonostante oltre due terzi delle aziende (72%) dichiarino di aver significativamente aumentato i budget per interventi dedicati al benessere, solo un lavoratore su quattro riconosce un impegno concreto da parte della propria impresa in tal senso e meno del 10% afferma di sentirsi bene dal punto di vista psico-fisico e relazionale. Il tema dell’ascolto fa spesso la differenza.
Il benessere del dipendente si manifesta anche in relazione alla relazione – il gioco di parole in questo caso è utile – che avverte in azienda. Il 50% delle aziende definisce le proprie strategie di benessere organizzativo in modalità top-down, dove priorità e obiettivi sono definiti dal vertice aziendale, senza un confronto interattivo per capire le reali esigenze delle persone.
In un’ottica «allargata» di sistema Paese, una maggiore offerta di servizi all’interno di un piano di corporate wellbeing porterebbe anche a un «alleggerimento» dei costi dell’assistenza e della previdenza pubblica. Passare da welfare a wellbeing conviene a persone, aziende e Paese perché mette al centro salute, soddisfazione e potenziale umano, migliorando produttività, competitività e contribuendo concretamente allo sviluppo socio-economico del Paese.
Leggi anche:
1. Dal pisolino in ufficio al maggiordomo aziendale, ecco i nuovi servizi di welfare
2. Welfare aziendale: 7 aziende su 10 si credono virtuose, ma non è così per i dipendenti
© Riproduzione riservata