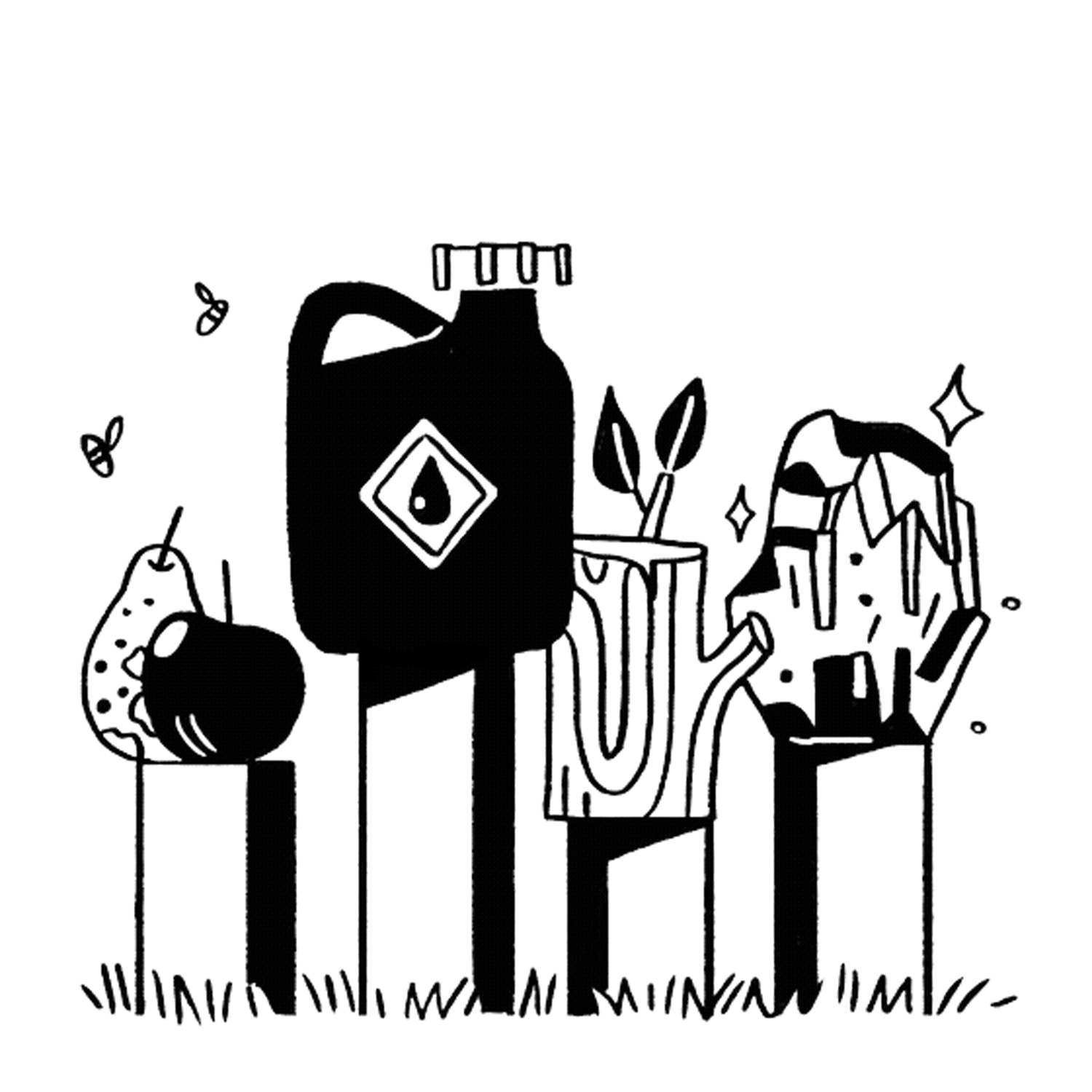Negli ultimi mesi, il mondo della finanza sostenibile si è trovato ad affrontare una questione delicata: può il settore della difesa essere compatibile con i criteri esg? La domanda è al centro di un dibattito che coinvolge investitori, regolatori e asset manager in tutta Europa. Se da un lato permangono forti barriere etiche e normative, dall’altro il nuovo contesto geopolitico impone una riflessione più pragmatica su sicurezza, resilienza e investimenti responsabili.
Armi controverse: il nodo regolamentare
Il primo aspetto da chiarire è la distinzione tra armi convenzionali e armi controverse. Le armi controverse – una categoria che comprende armi nucleari, chimiche, biologiche, mine antiuomo e bombe a grappolo – sono vietate da trattati internazionali e sistematicamente escluse dagli investimenti esg per ragioni legali e umanitarie. Le armi convenzionali, invece (carri armati, velivoli militari, armi da fuoco), non sono soggette a divieti normativi, ma sollevano comunque dubbi etici, soprattutto quando vengono vendute a Paesi coinvolti in conflitti. Il regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), attraverso l’indicatore PAI 14, richiede esplicitamente trasparenza riguardo l’esposizione ad armi controverse ma lascia margini di interpretazione per le armi convenzionali.
I dati: esg e difesa
Secondo un’analisi di MainStreet Partners, il 28% dei fondi esg valutati risulta investito in aziende attive nella difesa convenzionale. Di questi, il 18% è classificato come Articolo 8 e l’1% come Articolo 9, mentre il restante 9% è composto da fondi Articolo 6 o non classificati. Nel Regno Unito, la percentuale sale al 32% tra i fondi esg, un segnale chiaro che l’interesse verso il settore cresce, nonostante le complessità normative.
L’ostacolo del DNSH
Uno dei principali ostacoli è rappresentato dal principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), integrato sia nella SFDR, sia nella Tassonomia UE. L’intero comparto difesa è escluso dalla Tassonomia: il che non implica necessariamente che sia dannosa per l’ambiente ma impedisce alle attività del settore di essere classificate come sostenibili. Nel caso della SFDR, il DNSH si applica a livello aziendale e può essere interpretato in modi diversi: alcuni investitori escludono solo le armi controverse, altri applicano criteri più rigidi, eliminando qualsiasi azienda coinvolta in controversie, anche in assenza di violazioni accertate.
Esg non è sinonimo di investimento etico
Un punto spesso trascurato nel dibattito è la differenza tra integrazione esg e investimento etico. L’esg non è una valutazione morale ma un approccio alla gestione del rischio. L’esclusione di un intero settore non è una conseguenza automatica dell’analisi esg quanto piuttosto una scelta che può derivare da politiche d’investimento o da obblighi normativi. È per questo che, sebbene molti fondi continuino a escludere la difesa, altri iniziano a riconsiderarne il ruolo alla luce delle nuove priorità in termini di sicurezza.
Secondo diverse società dell’asset management è arrivato il momento di pensare a strumenti come i “Defence Bonds”, che permettano di finanziare in modo responsabile alcune attività legate alla sicurezza, distinguendo tra comparti potenzialmente allineabili alla sostenibilità (come la cybersicurezza o le tecnologie avanzate) e altri meno compatibili. Anche alcuni governi europei, come Regno Unito, Finlandia e Polonia, stanno rivedendo le posizioni storiche in tema di esclusioni, aprendo la strada a un cambiamento di prospettiva.
La sicurezza e sostenibilità
Il concetto di sostenibilità non può prescindere dalla sicurezza. Senza pace e stabilità, non è possibile raggiungere nessun obiettivo ambientale o sociale. Eppure, a oggi, i principali framework esg non considerano il ruolo della sicurezza come elemento chiave e il settore difesa non è considerato sostenibile secondo i criteri della Tassonomia Ue.
© Riproduzione riservata