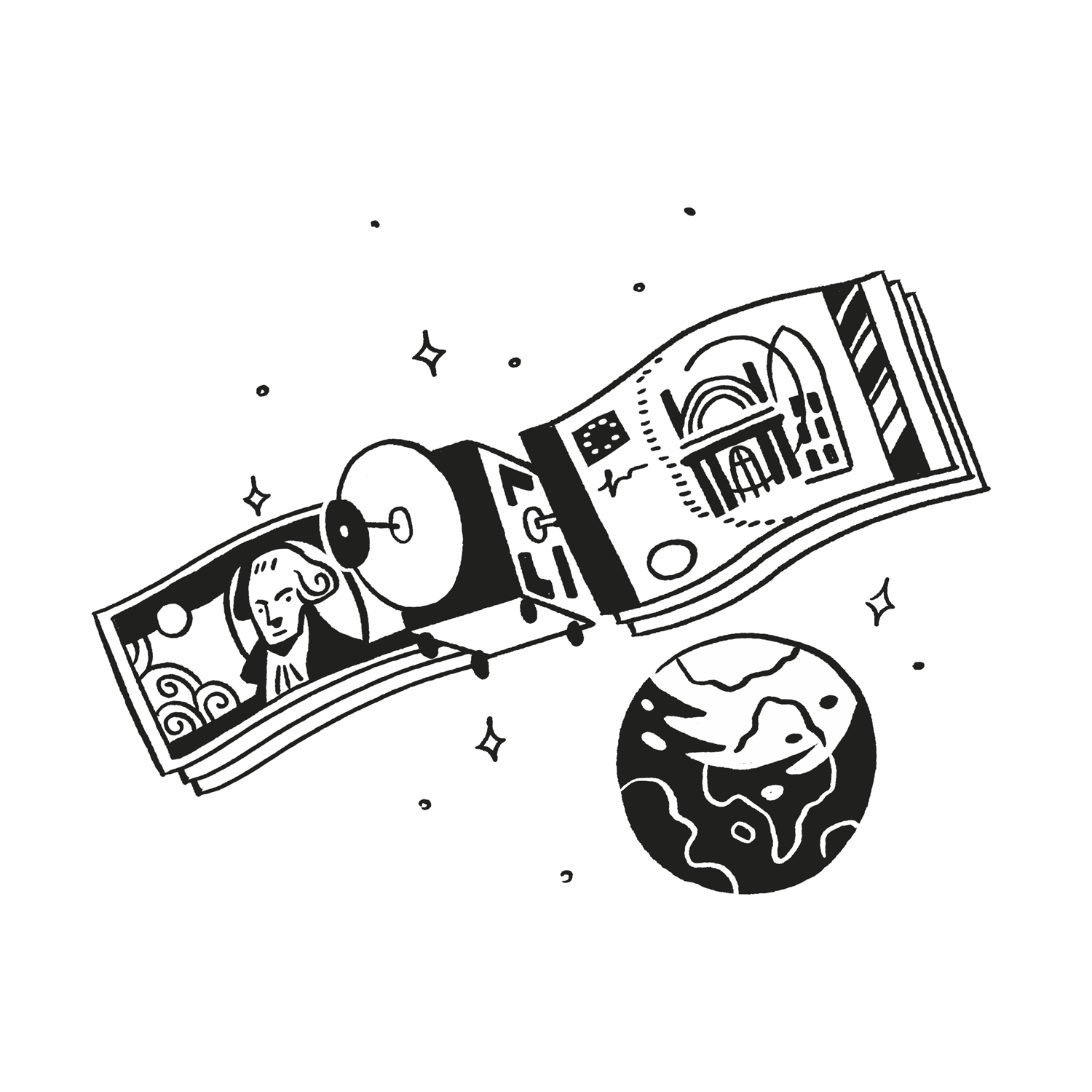Alcuni spettri, da un paio d’anni a questa parte, turbano il sonno dei grandi operatori del mercato dell’arte. Il primo tra tutti è la caduta libera del fatturato globale che non sembra arrestarsi: dopo il crollo registrato nel 2024 (-12% secondo l’ultimo report di Art Basel/Ubs, ma che diventa -26% per le sole case d’asta), si è assistito a un ulteriore calo (-7,6%) nel primo semestre di quest’anno.
A far paura al mercato, dicono gli osservatori, sarebbe soprattutto il clima di incertezza geopolitica globale (dazi compresi), foriero di una crisi che ha visto un taglio netto delle compravendite di fascia alta, quelle di opere sopra i 10 milioni di euro, diminuite del 45% nel 2024. Basti pensare che, malgrado i molti top lot battuti alle aste internazionali, quest’anno nessuna opera superiore ai 50 milioni è stata ancora venduta; nel 2022 furono sei.
Ma è davvero tutta colpa dei venti di guerra, delle improvvise giravolte di Trump, dell’espansione economica cinese e del timore recessione in Europa? Probabilmente no perché, andando ad analizzare nel dettaglio gli ultimi report, si scopre che il mercato dell’arte in crisi non è, ma sta progressivamente cambiando faccia: e ciò soprattutto in virtù di un cambio generazionale che vede i nuovi collezionisti con gusti e motivazioni assai differenti da quelli dei cosiddetti boomers, coloro che nel dopoguerra hanno contribuito alla creazione di un sistema come lo vediamo adesso. Anzitutto scopriamo che, se il fatturato globale sta crollando, è altrettanto vero che il numero di compravendite è di fatto salito del 3%, merito soprattutto delle transazioni “basse” – quelle di opere sotto i 5mila euro – che nel 2024 sono cresciute del 13 per cento. La crisi, insomma, se c’è riguarda solo il collezionismo degli ultraricchi che è lo stesso, sia ben chiaro, che in questi anni ha favorito una grande bolla speculativa. Lo stesso Noha Horovitz, Ceo di Art Basel, ammette un cambiamento di rotta: «Assistiamo a una sensibile contrazione del mercato alto, ma nuovi acquirenti si sono affacciati con decisione».
Ecco: oltre il 30 per cento dei nuovi acquirenti è rappresentato dalla generazione dei Millennial o addirittura della “Generazione Z”, i nati tra la metà degli anni ’90 e il 2010. L’identikit dei nuovi collezionisti under 40, in base anche a report di community come Avant Arte (oltre 3,5 milioni di utenti), risulterebbe molto diverso rispetto alla generazione precedente: imprenditori high tech o professionisti della comunicazione con meno disponibilità di spesa, ma grande sensibilità verso un’arte che rispecchi questi tempi e con cui si possa interagire attivamente. Ciò che li caratterizza è una costante e quasi onnivora ricerca di nuovi artisti attraverso i social network e i media digitali, un budget medio per gli acquisti (anche in aste online) non superiore ai 10mila euro annui e, a differenza del passato, nessun particolare interesse per autori che rappresentino un investimento economico o un elemento di status symbol. Sta cambiando anche il gusto: meno attenzione ai nomi storici e blasonati, ma tanta curiosità per le nuove tecnologie (compresi gli artisti e le opere IA) e per i “Passion Asset” (design, fotografia e cimeli sportivi) che hanno riscontrato una crescita dell’1,2 per cento.
E allora, cosa resterà del gigantesco mercato di opere costruito in questi decenni da gallerie, case d’aste e musei? E soprattutto, cosa succederà al mercato quando, nei prossimi vent’anni, la Generazione Z erediterà patrimoni – anche in opere d’arte – calcolati in 80mila miliardi di dollari? «Le nuove generazioni hanno gusti, criteri e priorità molto diverse, con una maggiore attenzione verso nuove forme di creatività e linguaggi più vicini alla contemporaneità – dice Franco Broccardi, fondatore dello studio Lombard Dca e dell’Osservatorio Arte Contemporanea – e il sistema dovrà trovare nuovi equilibri. Cosa succederà quando, per la prima volta, la ricchezza ereditata sarà superiore a quella prodotta? Alcune collezioni verranno disperse, altre entreranno in fondazioni e musei; è probabile che molte opere rientreranno sul mercato creando un eccesso di offerta e impattando sia sui prezzi delle opere stesse sia sulle difficoltà dei giovani artisti di entrare in un mercato saturo».
Leggi anche:
1. Destino dell’arte confiscata: il recupero dell’evasione può essere incorniciato
2. I caveau svizzeri come porti franchi, così Berna scuda le grandi collezioni
© Riproduzione riservata