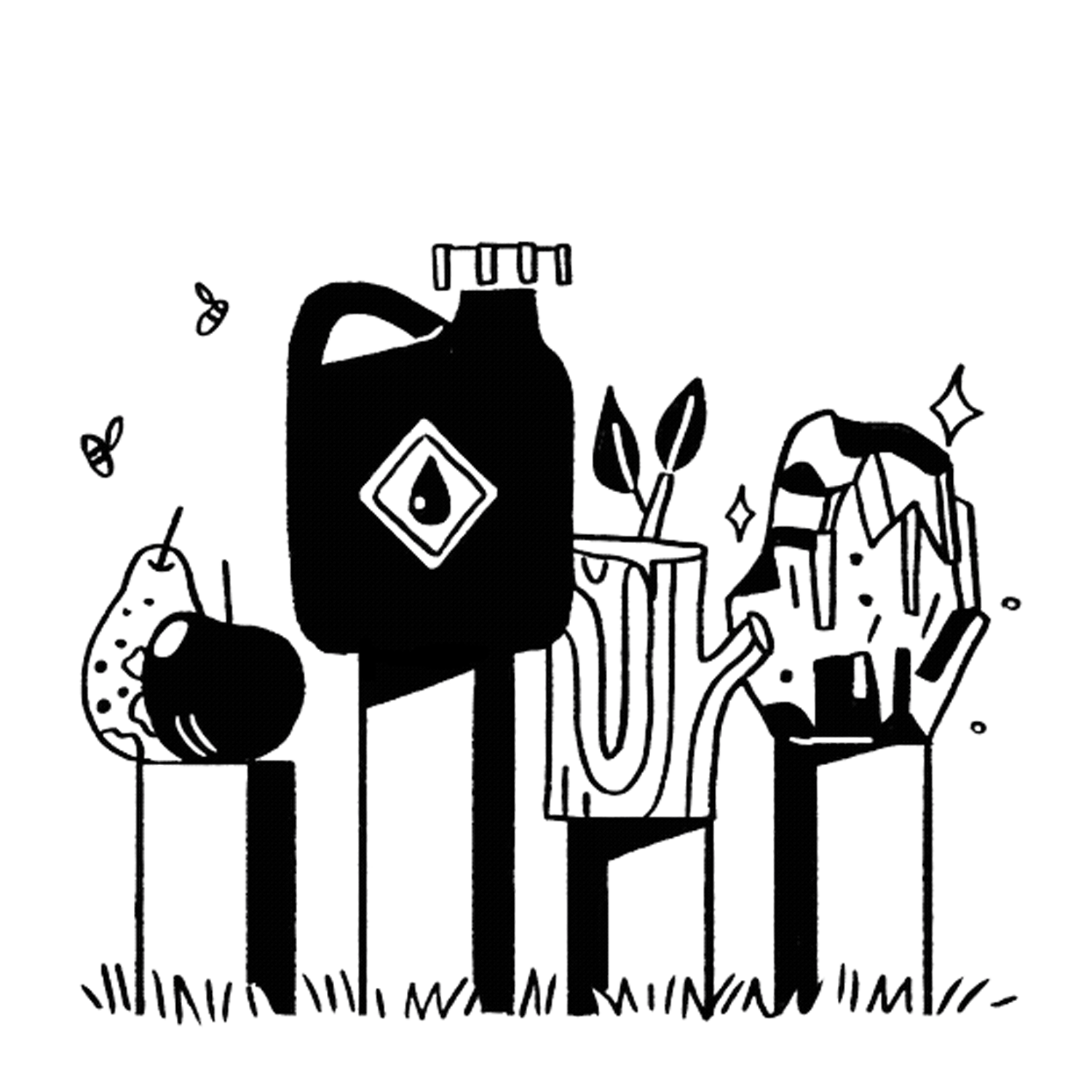Dall’invasione dell’Ucraina nel 2022, lasciare il mercato russo è diventata una priorità (e un rompicapo) per le banche europee. Il percorso è stato condizionato da tre vincoli: il quadro sanzionatorio Ue in continua evoluzione; l’obbligo, imposto da Mosca, di ottenere un decreto presidenziale per dismettere asset locali; la pressione delle autorità europee a ridurre rapidamente qualsiasi presenza operativa o rischio residuo. Non solo. Nel documento finale dell’ultima riunione dei ministri delle Finanze del G7 è stato aggiunto l’impegno affinché chiunque abbia fatto affari o favorito la Russia non entri nella ricostruzione dell’Ucraina. Più di un anno fa il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, aveva detto che devono sospendere le loro attività in Russia, poiché restare nel Paese comporta anche un «problema di reputazione». Richiesta avanzata per prima dalla Bce (con Unicredit che poi si era appellata al tribunale Ue).
Certo, uscire dalla Russia ha un prezzo. Qualcuno lo ha già pagato cedendo progressivamente le proprie attività con un impatto sul bilancio. Calcolare quanto è costata alle banche italiane l’uscita dalla Russia non è però semplice. Vanno considerate le svalutazioni delle partecipazioni in filiali/attività russe, i crediti inesigibili, i costi operativi legali/di compliance per l’uscita e la perdita di nuovi affari in Russia. Ma guardiamo le strategie seguite dalle singole banche, in particolare dalle big più esposte ovvero Intesa Sanpaolo e Unicredit. Partiamo dalla prima: l’esposizione cross border di Intesa verso la Russia al 30 giugno del 2022 era di 3,2 miliardi di euro. Al 30 settembre 2025 risulta meno di 300 milioni. A oggi l’esposizione verso la Russia degli impieghi del gruppo è scesa sotto lo 0,1 per cento. In sostanza, i prestiti della controllata russa sono prossimi allo zero, segnale di un de-risking quasi completo sul business locale. Dal 15 gennaio 2025 la banca guidata da Carlo Messina ha inoltre ristretto i pagamenti in euro provenienti da banche russe, con eccezioni limitate all’operatività interna del gruppo. L’effetto sui conti consolidati è stato gestibile proprio perché l’esposizione residua è marginale e iper-presidiata. Il costo industriale non è quantificabile ma è prevalentemente «opportunità mancata» (capitale immobilizzato e management time), più che perdite creditizie nuove.
Assai più tortuoso è stato il sentiero seguito da Unicredit che nel 2024 ha impugnato in sede Ue le richieste della Bce di accelerare il ridimensionamento in Russia, senza ottenere la sospensiva. In parallelo, ha subito in Russia sequestri su asset collegati a garanzie rilasciate in passato e ha dovuto accantonare maggiori rischi legali. Nel 2025 il contenzioso prosegue, con sentenze sfavorevoli in tribunali russi su obbligazioni di pagamento bloccate dalle sanzioni.
Leggi anche:
Unicredit lascerà la Russia entro il 2026
La Russia fa il pieno di gas alla Cina
Il 3 novembre scorso, l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha confermato al Financial Times che il ritiro dell’istituto di credito dalla Russia prosegue, anche se rallentato dai vincoli imposti da Mosca. La volontà di lasciare il Paese resta «assolutamente chiara», ha detto il banchiere. Il processo è solo frenato da ostacoli legali e regolamentari introdotti dal Cremlino per limitare l’uscita degli operatori occidentali. Secondo quanto riferito da Orcel al quotidiano della City, gli sforzi per ridurre l’esposizione russa, su cui Francoforte continua a esercitare pressioni, «sono ancora in corso» e la filiale sarà «praticamente eliminata» dal perimetro del gruppo entro il prossimo anno. «Oggi è una banca molto piccola che non ha più quasi nessun impatto sul nostro gruppo», ha detto l’ad, assicurando che non vede grossi rischi. Il massimo potrebbe essere la nazionalizzazione ma, ha aggiunto, «sarebbero 75-80 punti base di capitale» che sono assorbibili. I prestiti locali netti oggi ammontano a 700 milioni di euro dai 6,9 miliardi del 2022, i depositi ammontano a 900 milioni (7,7 miliardi nel 2022). L’impatto di perdita estrema sul Cet1 è di 79 punti base dai 128 del 2022. I pagamenti cross-border sono inferiori a 5 miliardi (limitati a euro e dollari in uscita) mentre a marzo 2022 erano sopra 25 miliardi. Secondo quanto riportato a inizio del mese scorso dal quotidiano economico russo Kommersant, Unicredit «sta gentilmente allontanando i clienti esistenti e impedendone l’ingresso a quelli nuovi». Sottolineando che ora la maggior parte delle commissioni sono quintuplicate, passando da 20.000 a 30.000 rubli al mese e raddoppieranno ulteriormente, passando da 40.000 a 60.000 rubli al mese, a partire dal 1° dicembre. Secondo i bilanci russi, al 1° luglio 2025 le attività della banca ammontavano a 736 miliardi di rubli (la seconda più grande tra le banche di proprietà estera), con un calo del 13,6% da inizio anno. L’utile netto della banca per il primo semestre del 2025 ha superato i 39 miliardi di rubli, con un aumento del 34% su base annua. Da inizio 2024 al 1° settembre 2025, il portafoglio prestiti corporate di Unicredit Bank è diminuito a 29 miliardi di rubli e il portafoglio retail a 47,5 miliardi di rubli. Nello stesso periodo, i saldi dei conti delle organizzazioni non governative sono diminuiti a 164 miliardi di rubli (-1,6%), i depositi delle persone giuridiche a 54,5 miliardi (-4,3%) e i depositi individuali del 5% a 13 miliardi di rubli.
In generale, eventuali scossoni legali potrebbero riflettersi su accantonamenti e su richiesta di capitale gestionale. Senza dimenticare la reputazione e la strategia domestica: il governo Meloni aveva approvato l’operazione di Unicredit sul Banco Bpm ma con una serie di prescrizioni, tra cui proprio quella di interrompere le sue attività in Russia, a eccezione dei pagamenti delle aziende italiane in loco che si troverebbero in difficoltà, entro l’inizio del 2026. Quindi, la permanenza – anche se «ibernata» – può condizionare operazioni strategiche in Italia e in Ue.
© Riproduzione riservata