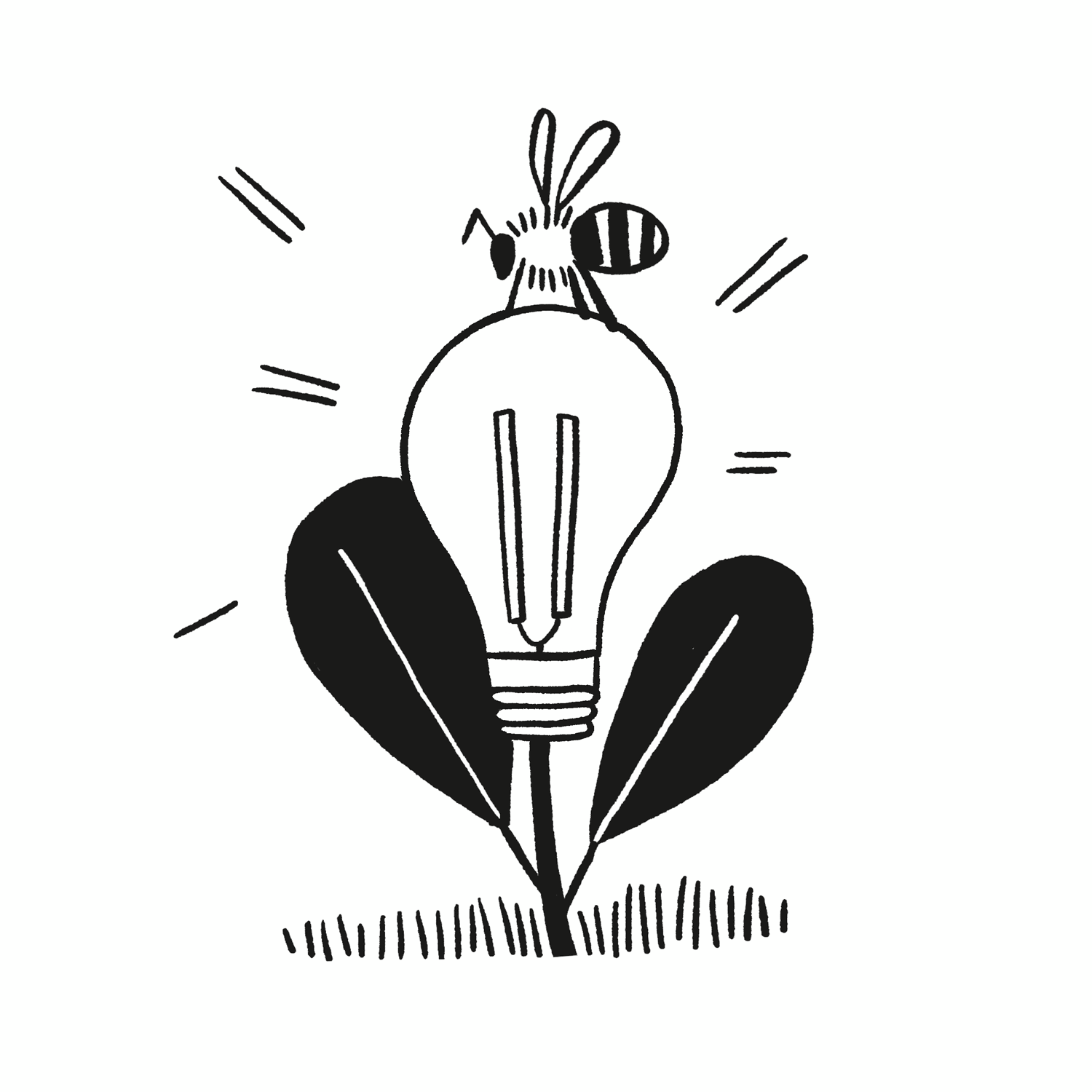Chiede l’intervistatrice: «Siete favorevoli alla fusione di Mps con Mediobanca?». Risponde Francesco Milleri, dominus di Delfin: «Non tocca a me decidere, ma alla banca. Le scelte le farà solo il management». Sicché ora abbiamo una certezza: Delfin è pronta ad approvare il progetto di fusione che l’amministratore delegato della banca senese Luigi Lovaglio si prepara a sottoporre all’esame del cda. Non è una novità assoluta, ma un conto sono le indiscrezioni sulle interlocuzioni tra Lovaglio e l’avvocato Sergio Erede – che rappresenta Milleri – altro è il via libera espresso pubblicamente. Il che significa che in seno all’azionariato di controllo di Mps (Delfin al 17,5% e il Gruppo Caltagirone all’11,5%, entrambi autorizzati a salire al 20%) rischia di allargarsi una pericolosa crepa, vista la diversa opinione sul progetto Lovaglio coltivata da settimane dall’imprenditore capitolino, seguito da una parte del cda.

Pensare che le condizioni affinché l’operazione Mps–Mediobanca diventasse un tassello ordinato di rafforzamento del sistema bancario italiano c’erano tutte: numeri, sinergie, perfino una narrazione patriottica. Costruire un polo più solido, più competitivo, capace di parlare con maggiore autorevolezza alla Bce e ai mercati. Invece prende forma l’impressione opposta: che si stia imboccando un sentiero stretto, costoso e divisivo. Un sentiero che rischia di trasformarsi in un Vietnam finanziario, logorante per i soci e destabilizzante per il sistema.
I fatti, prima delle opinioni. Lovaglio considera il delisting di Mediobanca e la successiva fusione in Mps l’unica strada per centrare i 700 milioni di sinergie promessi alla Bce al momento dell’Opas. È una tesi legittima. Ma non è un dogma. E soprattutto non è – stando ai documenti – un obbligo regolamentare. Il prospetto è chiaro: con una partecipazione inferiore al 90% (oggi Mps possiede l’86% di Mediobanca) è previsto il mantenimento della quotazione, salvo problemi di flottante. L’integrazione, inoltre, non richiede necessariamente una fusione per incorporazione. Il delisting è quindi una scelta strategica, non una condizione imposta dall’Europa.
Primo nodo. Ai valori attuali, l’offerta su Mediobanca incorpora un premio significativo rispetto alle quotazioni di mercato. Il differenziale, amplificato dall’andamento divergente dei titoli, rende l’operazione più onerosa di quanto apparisse in autunno. Sommando il costo dell’eventuale delisting e quello necessario ad attivare le sinergie, il conto complessivo impone prudenza. Spendere non meno di 3,5 miliardi per inseguire 700 milioni di risparmi stimati non è un esercizio teorico: è una scommessa industriale ad alto rischio esecutivo. Le dimensioni non sono comparabili, ma per logica finanziaria l’eco di Antonveneta – diciotto anni fa – torna inevitabilmente alla memoria.

Secondo nodo. Mediobanca non è una banca come le altre. La ricostruzione storica di Angelo De Mattia (che pubblichiamo a pagina 7) lo ricorda: istituto nato tricefalo, con uno statuto peculiare, protagonista per decenni di un equilibrio delicato nel capitalismo italiano. Una stanza di compensazione del sistema, un perno attorno al quale si sono composti conflitti e costruite architetture finanziarie complesse. Il Testo unico bancario del 1993 ne ha limitato i privilegi, ma nessuno – nemmeno nei momenti più turbolenti – ha ritenuto che l’assorbimento puro e semplice fosse la soluzione naturale. Non per nostalgia, ma per realismo sistemico.
L’operazione viene oggi presentata come un passo lineare verso l’efficienza. Ma l’efficienza non è solo una somma di costi tagliati e strutture accorpate: è stabilità degli assetti, prevedibilità delle regole, coerenza tra strategia industriale e profilo istituzionale. In Piazzetta Cuccia il malcontento è diffuso. Nel dopo fusione potrebbe tradursi in una fuga di professionalità, mentre concorrenti come Deutsche Bank e Julius Baer si stanno già muovendo.
Terzo nodo. Indagini giudiziarie, tensioni tra soci, Consob in osservazione, volatilità di mercato. Non è il clima ideale per un’operazione trasformativa. Le grandi fusioni bancarie richiedono compattezza e chiarezza di obiettivi. Qui si naviga tra contrapposizioni e incertezze, con il rischio di alimentare una volatilità che premia gli operatori più aggressivi e penalizza gli azionisti di lungo periodo. Il paradosso è evidente: un’operazione che potrebbe rafforzare il sistema Italia – se concepita come integrazione graduale e finanziariamente sostenibile – rischia di trasformarsi in un conflitto permanente, erodendo prima il capitale reputazionale e poi quello finanziario.

Solo una mediazione tra management e soci può evitare la deriva. Mediazione non significa arretramento, ma scelta della soluzione meno traumatica. Preservare la quotazione di Mediobanca, concentrare l’integrazione sulle aree di maggiore complementarità e valutare una fusione mirata tra Widiba e Mediobanca Premier nel wealth management, accompagnata da un taglio dei costi più deciso e strutturale, consentirebbe di estrarre sinergie senza smontare in blocco un’architettura che ha ancora un peso sistemico.
La domanda non è se Mps e Mediobanca possano integrarsi. La domanda è a quale prezzo, con quali garanzie di stabilità e con quale architettura di governance. Un’operazione bancaria non è una partita di risiko tra amici. Se diventa una guerra di logoramento tra soci, manager e istituzioni, il rischio non è solo mancare i 700 milioni di sinergie. È minare la fiducia nel sistema nel suo complesso. E il sistema bancario italiano, dopo un decennio di ricapitalizzazioni e salvataggi, non può permettersi un altro Vietnam.
Leggi anche:
Un compromesso per Mediobanca: fuori dal listino ma non un addio
Mps, concerti presunti e conflitti reali
© Riproduzione riservata