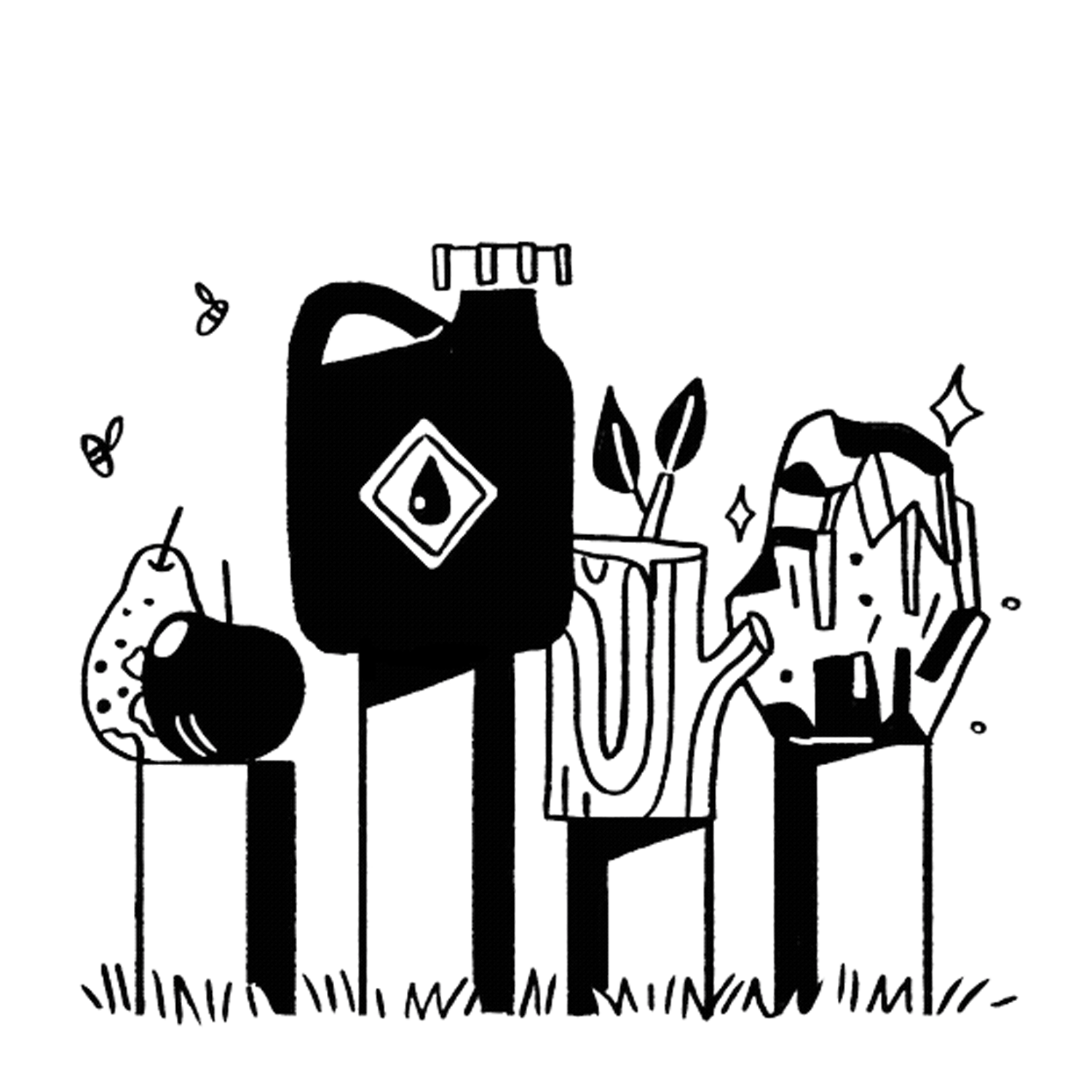Nel 1997 David Bowie aprì nuove strade a Wall Street raccogliendo 55 milioni di dollari dalle future royalty del suo catalogo con un rendimento del 7,9 per cento. Bowie a un certo punto stava pensando di vendere le sue canzoni. Ma poi si è reso conto che erano sue e non voleva farlo. Quando il cantante si recò nell’ufficio di un investment banker nel centro di Manhattan, il banchiere suggerì un’innovativa strategia di ingegneria finanziaria: indirizzare il flusso futuro di guadagni derivanti dai suoi primi 25 album verso un veicolo finanziario separato, per poi utilizzarlo come garanzia per un’obbligazione, cedendo i diritti sulla sua musica, ma solo temporaneamente. Il tempismo fu perfetto: l’accordo fu siglato prima che Napster e simili facessero crollare le vendite di musica registrata. Ovvero prima che download digitali iniziassero a cannibalizzare le vendite dei dischi.
All’epoca, però, i “Bowie Bond” erano considerati un esperimento eccentrico: troppo di nicchia, troppo esotici, troppo imprevedibili. James Brown e altri seguirono l’esempio, ma per due decenni simili accordi rimasero una curiosità. Anche big come Nomura e la Royal Bank of Scotland hanno tentato di accorpare i flussi di reddito futuri di un gran numero di artisti per diluirne il rischio però la maggior parte degli artisti non aveva un corpus di opere sufficientemente ampio da fornire flussi di cassa costanti per garantire un’obbligazione. Nel 2004, la società di rating Moody’s declassò gli stessi “Bowie Bond”, citando le vendite inaspettatamente deboli nell’industria discografica.
La svolta
Ma oggi è arrivata la svolta. Perché quest’idea, un tempo innovativa, è diventata un mercato da 4,4 miliardi di dollari solo quest’anno, superando i 3,3 miliardi di dollari raccolti nel 2024 e di gran lunga superiori ai 300 milioni di dollari registrati nel 2021. I principali attori che stanno trattando i titoli garantiti da attività musicali (ABS) come un aspetto importante della finanza strutturata sono Blackstone, The Carlyle Group, Apollo Global Management, KKR e persino il fondo pensione statale del Michigan. Tra le operazioni recenti figurano le cartolarizzazioni legate ai cataloghi di Justin Bieber, Lady Gaga, Pink Floyd e Beatles.
Bob Valentine, amministratore delegato della casa discografica Concord con sede a Nashville, ha dichiarato al Financial Times: «Quando abbiamo concluso il nostro primo accordo nel 2022, avevamo un rating da un’unica agenzia di rating, il che era ottimo, ma era ancora un periodo di apprendimento per vedere come si sarebbe evoluto. Ora sono passati quattro anni e gli investitori hanno capito che è un’operazione sicura».
Concord, la cui maggioranza è detenuta dal fondo pensione statale del Michigan, ha completato la sua prima importante cartolarizzazione musicale nel 2022, vendendo 1,8 miliardi di dollari in obbligazioni legate alle canzoni di Cyndi Lauper e dei Pink Floyd. Da allora ha visto triplicare il numero di account che si presentano agli incontri di presentazione. Altro esempio: un finanziamento da 372 milioni di dollari da parte di Recognition Music, garantito dai diritti vincolati alle canzoni dei Red Hot Chili Peppers, Justin Bieber e Shakira, è stato quotato a un rendimento del 5,6% ad agosto. Secondo il fornitore di dati ICE Data Services, questo rendimento era di circa un punto percentuale superiore a quello di un’obbligazione societaria statunitense con rendimento e scadenza simili.
Per gli artisti, le scelte restano diversificate. Alcuni, come Bieber, hanno venduto il proprio catalogo ottenendo una somma immediata ma rinunciando agli incassi futuri. Altri mantengono i diritti, beneficiando dei proventi generati nel tempo. La forte attenzione di Wall Street solleva anche dubbi sulla disponibilità di cataloghi di valore: molti grandi nomi, da Bob Dylan a Bruce Springsteen, sono già stati acquisiti.
Ma perché Wall Street sta puntando sulle royalties musicali facendolo diventare un mercato multimilionario? L’interesse resta altissimo, spinto dalla crescente pressione sui colossi discografici quotati in Borsa a mantenere ritmi di crescita sostenuti. I flussi di cassa sono prevedibili e simili alle rendite. Lo streaming ha trasformato il consumo di musica in un modello stabile basato su abbonamento. Le royalty sono meno cicliche rispetto a molti ricavi aziendali. I rendimenti, inoltre, sono assai interessanti: un ABS musicale da 372 milioni di dollari il mese scorso, garantito dai diritti dei Red Hot Chili Peppers e di Shakira, ha registrato un rendimento del 5,6%, circa 100 punti base in più rispetto a un’obbligazione societaria con rating simile. Non solo. Una volta prive di rating, queste operazioni vengono ora regolarmente valutate da S&P Global Ratings, Moody’s Ratings e Fitch Ratings. Infine, va considerato il vantaggio della diversificazione: le royalty musicali sono in gran parte non correlate al reddito fisso o alle azioni tradizionali, il che fornisce una copertura nella costruzione di un portafoglio più ampio.
Il risultato? Questa asset classe sta diventando istituzionalizzata. La cartolarizzazione da 1,8 miliardi di dollari di Concord nel 2022 (sostenuta da Pink Floyd e Cyndi Lauper) ha contribuito ad aprire la strada.
Da allora, la partecipazione degli investitori è triplicata, con una domanda costantemente superiore all’offerta. Certo, il mercato è ancora relativamente piccolo rispetto ai settori tradizionali degli ABS come i prestiti auto o i crediti delle carte di credito, ma la direzione è chiara: con un capitale abbondante in cerca di rendimento, i prodotti strutturati legati alla proprietà intellettuale (che si tratti di musica, brevetti farmaceutici o persino hardware di intelligenza artificiale) non sono più marginali.
Leggi anche:
1. Wall Street gioca a Roblox, il gaming si fa largo nei portafogli
2. Tesori da giradischi: dai Pink Floyd a De André, ecco le incisioni top
© Riproduzione riservata